IL PARLAMENTO: A CURIA O A EMICICLO? AULE VETUSTE E CONTAGIOSE
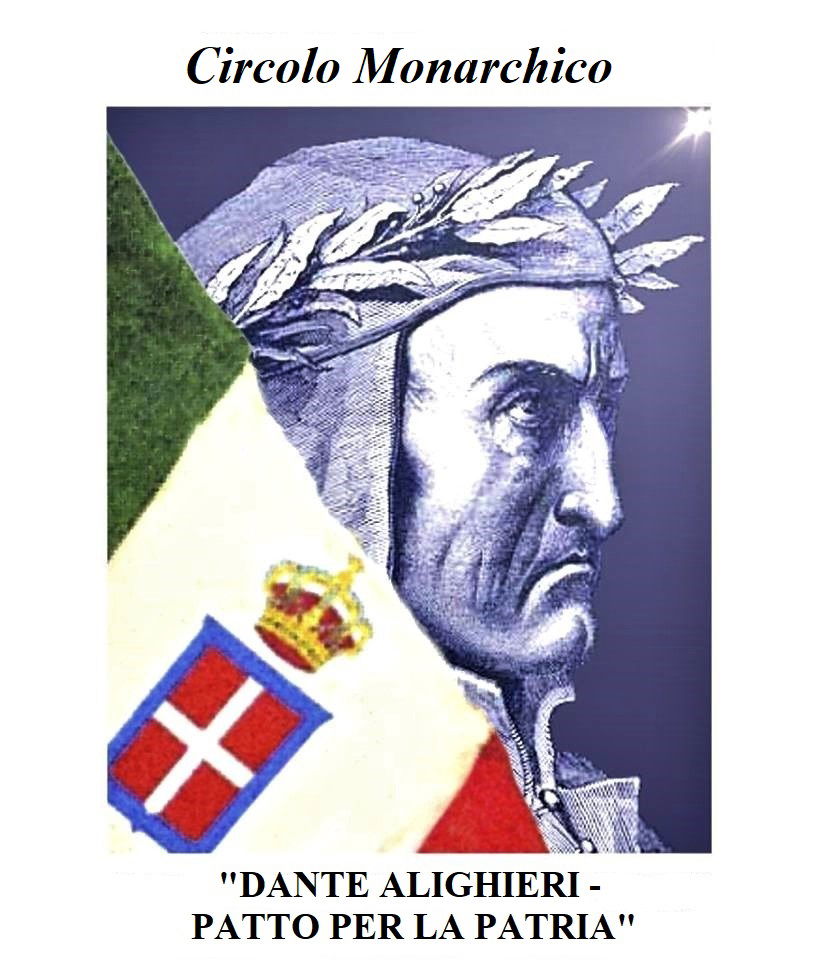
Che tristezza vedere il Parlamento deserto, mentre infuria la tempesta virale. Scranni vuoti come il senso di responsabilità di chi li occupa in tempi di quiete. Ne parla il prof. Aldo Mola in questa lucida analisi tratta dal Giornale del Piemonte.
In memoria di Marco Papirio
Anche per il Parlamento la forma è sostanza. Fa riflettere lo spettacolo fornito in questi giorni dalle Aule di Montecitorio e di Palazzo Madama. Mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte mercoledì e giovedì sciorinava “molto è stato fatto e molto resta da fare”, lasciando ai posteri l'ardua sentenza su meriti e demeriti del barcollante governo in carica, l'occhio dello spettatore andava sbigottito agli scranni vuoti, alle fronti corrugate, o inutilmente spaziose, contratte da mascherine variegate, alla desolazione di un rito celebrato senza pubblico né giornalisti. Preso atto dell’elusiva promessa di future “informative” ogni quindici giorni da parte dell’esecutivo, è lecito domandarsi: quanti ministri deve avere il governo se poi quelli in Aula (con dichiarazioni fatue: è il caso della titolare dell'Istruzione) si contano sulla dita di una mano? E ancora: servono davvero 630 deputati e 315 senatori o ne possono bastare 200 e 100, rispettivamente? Le spettrali sedute dei giorni scorsi anticipano nei fatti l'esito del referendum confermativo della legge che ha ridotto il numero dei parlamentari: una consultazione popolare che non potrà certo essere rinviata “sine die”. Per quel che deputati e senatori mostrano di saper e voler contare, invero, la loro latitanza dalle Aule induce a restringerne ulteriormente i ranghi, a tutto vantaggio della concentrazione del potere nelle mani di una ristrettissima cerchia di tecnocrati, per nulla bisognosi di consenso elettorale e quindi indifferenti al malumore che sale dal Paese.
Altri due mesi di mancate sedute plenarie affosserebbero la credibilità di un Parlamento incapace di rispondere, sia pure in via provvisoria, a sfide eccezionali. In presenza dell'emergenza sanitaria che impone di tenere le distanze tra persone non documentatamente infette, Roma e l'Italia intera mancano forse di “contenitori” capaci di assicurare la partecipazione di tutti i parlamentari? Ridurli a una manciata di “selezionati”, scelti dai loro capibastone, significa svuotare di rappresentatività gli organi parlamentari. Il confronto va, nella memoria, al senatore romano Marco Papirio che nel 390 a.Cr., mentre tutti (militari e popolani) erano fuggiti per scampare al saccheggio dell'Urbe, rimase seduto al suo posto; talché uno dei Galli gli tirò la barba per vedere se fosse vivo e, da barbaro qual era, lo uccise.
Nella Roma dei Consoli e dei Cesari, il Senato si radunava nella Curia che dal Foro continua a dare lezioni al tempo presente. Rettangolare, 18 metri di larghezza, 27 di lunghezza e 21 di altezza (proporzioni perfette anche per l'acustica), essa è percorsa ai lati maggiori da tre gradini bassi e larghi che assicuravano accesso facile e comoda seduta (molti “patres”, reduci da gloriose battaglie, soffrivano di acciacchi alle giunture). Sul fondo dell'Aula non troneggiava un presidente: vi si ergeva, invece, l'Altare della Vittoria, rimosso una prima volta da Costanzo II e infine da Teodosio nel 384 d.Cr. su intimazione del vescovo di Milano, Ambrogio (poi santo). Fu la prima sconfitta della Romanità e della Forma che è anche Sostanza, dell’aristocrazia del Merito, tipico di un Ordine fondato sul confronto tra Pari. Ognuno si alza, parla breve e siede. L'Aula vota. Decide “erga omnes”, come insegnano i due altorilievi traianei che decorano la Curia romana: la remissione dei debiti e i prestiti agricoli a beneficio dei bambini poveri, sintesi della “Res publica” che nelle insegne recava il motto “Senatus populusque romanus”.
Aule contagiose
La forma del Senato romano ha un'unica replica negli Stati retti da Parlamenti, di qua e di là dell'Atlantico: quella dei Comuni e dei Lord a Palazzo Westminster a Londra. Due file di banchi contrapposti, separati da uno spazio strettissimo, tutti vegliati dallo “speaker”, garante dell'ordine dei lavori. L'“Inghilterra” sarebbe tale e quale è se il suo Parlamento avesse aule a emiciclo come nella generalità dei Paesi al di qua della Manica? Dopo l'incendio che nel 1834 distrusse quasi completamente l'edificio preesistente, gli inglesi avrebbero potuto mutare stile. Invece l'architetto Charles Barry ripristinò l'allestimento originario; anzi nel trentennio 1837-1868 lo vestì in panni gotici, più solenni e “antichi”, con le Torri dell'Orologio e Victoria. Quel passato remoto, sorto appena ier l'altro, segna la distanza tra la quotidianità e la Storia; ricorda che ogni decisione odierna ha radici nel passato e deve guardare alle generazioni venture.
Con le Rivoluzioni di fine Settecento l'Occidente ebbe la grande occasione di prendere esempio dalla prima monarchia parlamentare e fare altrettanto. La dichiarazione d'indipendenza delle colonie della Nuova Inghilterra a Philadelphia (1776) e il “giuramento” nella Sala della Pallacorda a Parigi, ove rappresentanti di borghesia, clero e aristocrazia s'impegnarono a non separarsi e poi si proclamarono Assemblea nazionale (1789), avvennero in sale rettangolari, assai disadorne. Eppure cambiarono il mondo. L'emiciclo venne a assunto a modello solo nel corso dell'Ottocento. Tra i suoi massimi esempi è il Palazzo del Congresso a Washington, che in un unico edificio comprende le due Camere. Gli “americani” ebbero tutto il tempo di pensarci. Il loro parlamento originario fu incendiato dagli inglesi nel 1814. L'attuale, il Campidoglio, venne eretto tra il 1851 e il 1867, ma nelle forme ritenute classiche: con le aule a “teatro”, replicate di Paese in Paese, dall'Austria alla Prussia e all'Ungheria, dall'Argentina al Messico. Altrettanto del resto aveva fatto la Francia della Restaurazione, che allestì per i deputati l'aula a Palazzo Borbone (1828-1833), già sede dei Cinquecento, e per i senatori quella di Palazzo di Lussemburgo (1836-1841).
Dalla ex Sala da Ballo di Palazzo Carignano a Montecitorio
Quando istituì il Parlamento con lo Statuto del 4 marzo 1848 Carlo Alberto di Savoia, all'epoca re di Sardegna, mise a disposizione due edifici “di famiglia”. Il Senato, che all'inizio contò una sessantina di membri, fu allocato a Palazzo Madama, in Piazza Castello, due passi da Palazzo Reale. Ai “patres” fu riservato un salone molto sobrio. Per i 208 componenti della Camera dei deputati (che all'epoca comprendeva anche i rappresentanti della Savoia e del Nizzardo) nella sala da ballo di Palazzo Carignano, da tempo dismessa, fu allestita alla svelta la celebre Aula lignea che tuttora si ammira, con tanto di segnaposto a ricordo di quanti vi sedettero. Essa calcò il modello d'Oltralpe: una cavea che diede impulso al corso politico del Regno. Il connubio tra il liberale Camillo Cavour e il democratico Urbano Rattazzi, germe del futuro trasformismo perpetuo, fu favorito anche dalla distribuzione degli scranni, propizia alla circolarità dei programmi e ai compromessi anziché alla loro contrapposizione. Gli oppositori duri e puri (cattolici e democratici intransigenti) finirono relegati agli estremi. In un'aula che registrava continuamente rumori e brusii, difficilmente le loro voci giungevano sino al banco del governo e della presidenza. Cadevano nell'indifferenza.
Con l'VIII legislatura del regno subalpino (1860) la Camera salì a 443 componenti. Bisognò approntare in fretta una nuova sede. Torino non ne aveva alcuna. Benché fosse tempo di statizzazione dei beni degli ordini ecclesiastici “contemplativi”, non vi erano edifici religiosi che si prestassero al caso. La città contava anche molte caserme, ma nessuna era atta ad accogliere i rappresentanti di un'Italia in parte federalista, rivoluzionaria, garibaldina, con frange mazziniane. Per i senatori Palazzo Madama bastò qual era, anche per il modesto numero di presenti, di rado superiori ai 50-60 membri, come ricordano i pochi studi sulla Camera Alta (sempre meritorio quello di Spartaco Cannarsa), poco indagata perché i “patres” non erano preda di fazioni litigiose e quindi risultano meno attraenti per una “storiografia” indulgente, su influsso britannico, al pettegolezzo e all'autoflagellazione.
Con somma rapidità venne pertanto allestita un'aula lignea nel cortile di Palazzo Carignano. Fu la grande occasione: tornare alla Curia romana, meno costosa e più pratica, con due file di banchi a gradoni ai lati e sul fondo presidenza, governo e palco reale per le grandi occasioni. Invece venne replicato il modello della Camera subalpina: l'emiciclo, completo di tribune per ex deputati e giornalisti, guardia nazionale, esercito e pubblico. Spazi appositi furono riservati a senatori, “signore”, corpo diplomatico, magistrati e consiglieri di stato.
Il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, decisa il 15 settembre 1864 e attuata l'anno seguente, rese però superflua quell'aula. Nella nuova capitale al Senato fu assegnato l'angusto teatro mediceo nel Palazzo degli Uffizi. La Camera ebbe il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, che sembrava fatto apposta per ospitarne i componenti, ma a sua volta fu pesantemente rimaneggiato per replicare il modello torinese, benché incompatibile con la sua severità originaria. Ancora una volta non venne colta l'occasione.
Dopo l'acquisizione di Roma (20 settembre 1870) il Regno d'Italia ricorse all'“usato sicuro”. Il Quirinale, residenza estiva dei papi, divenne il Palazzo Reale. Il Senato si insediò nel mediceo Palazzo Madama; la Camera a Palazzo Ludovisi, edificato a metà Seicento da Lorenzo Bernini sul Monte Citorio. I ministeri furono sparpagliati in vari edifici storici. La Pubblica Istruzione s’installò nell'ex convento domenicano a piazza della Minerva: bene augurante quando ministri erano Michele Coppino e Francesco De Sanctis. L'unico palazzo ministeriale costruito ex novo fu quello delle Finanze, che richiese molti anni.
L'aula di Montecitorio si mostrò subito inadeguata: irrimediabilmente torrida d'estate e gelida d'inverno. Causò innumerevoli malanni ai suoi frequentatori assidui: più agli impiegati, quindi, che ai deputati e ai ministri. Si pensò pertanto a una scelta coraggiosa: edificare un grandioso palazzo per i due rami del Parlamento, che fosse anche monumento funebre di Vittorio Emanuele II, il Padre della Patria provvisoriamente sepolto al Pantheon. Doveva sorgere sull'altura di Magnanapoli, incombente sull'attuale Foro Traiano, due passi dal Quirinale e non lontano da Termini.
Ma per la terza volta la Nuova Italia mancò di coraggio. I vari concorsi (per il monumento di Re Vittorio, per il Palazzo onnicomprensivo...) ebbero esiti importanti, ma solo per gli studiosi di storia dell'architettura. Nei fatti, zero. Nel 1889 il governo presieduto da Francesco Crispi lanciò una nuova gara. L'Italia che già possedeva l'Eritrea e si riteneva tutrice dell'Impero d'Etiopia aveva diritto a un Palazzo di Rappresentanza degno delle sue ambizioni. Invece, niente. Si ripiegò sull'ammodernamento dell'“Aula Comotto”, cosiddetta dal suo navigato ideatore. Vi lavorò Ernesto Basile, con gli scultori Domenico Trentacoste e Davide Calandra, subalpino, che nell'altorilievo bronzeo dominante il seggio presidenziale sintetizzò novecento anni di Casa Savoia, da Umberto Biancamano a Vittorio Emanuele II, re costituzionale.
Mitridatizzati all'orrore?
La Camera colà radunata non sempre si mostrò pari alla sua missione storica. Più volte risultò succuba di intrighi e prepotenze. Nel maggio 1915 cedette a Salandra. Nel 1922 a chi la oltraggiò asserendo che avrebbe potuto farne bivacco dei suoi manipoli. Umiliata e offesa tacque. Succuba, votò a favore. Dalla Grande Guerra (come poi dal suo devastante prolungamento, nel 1940-1945) milioni di giovani e meno giovani tornarono con la morte negli occhi. Per molti mesi videro quanto non avrebbero mai immaginato nella quiete del loro lavoro rurale e manifatturiero, nelle prime industrie metallurgiche e meccaniche. Una cosa era fabbricare automobili, un'altra la vita di trincea. Da quegli orrori i combattenti non tornarono affatto “migliori” bensì assuefatti alla violenza, come si vide nella guerra civile di bassa intensità sino al 1925. V'è motivo di domandarsi come gli italiani usciranno dall'“emergenza” attuale dopo mesi di martellamento televisivo di ambulanze a sirene spiegate, personale sanitario in condizioni estreme, morenti, bare... Che impressione ne rimarrà nei bambini e negli adolescenti? La “psicologia delle folle” fiorente da un secolo e mezzo insegna quali siano le ripercussioni degli spettacoli crudeli. Ma per capirlo bastano gli affreschi medievali di roghi e supplizi contornati da fanatici mitridatizzati al “male” e quindi più inclini a reiterarlo. Lo spettacolo quotidiano della morte non suscita buoni sentimenti.
Dalla guerra l'Italia uscì divisa
La storia, quella vera, non la retorica, ci dice che dalla seconda guerra mondiale e dalla connessa “guerra civile” dilagata soprattutto nell'Italia settentrionale e inasprita tra l'autunno 1944 e il maggio 1945 gli italiani non uscirono affatto “uniti”. Una parte continuò a mirare al bagno di sangue purificatore, completo di eliminazione fisica della “borghesia”. Altri sperarono che gli anglo-americani fermassero i “rossi” al confine orientale e aiutassero la Ricostruzione iniziata dal settembre 1943. La preoccupazione di Alcide De Gasperi, Luigi Einaudi e Giuseppe Saragat fu di escludere dal potere effettivo i comunisti di Palmiro Togliatti, mentre il socialista Pietro Nenni ne era succubo e, con l'eccezione di Ugo la Malfa e Ferruccio Parri, anche il borghesissimo partito d'azione inclinava a sinistra per anticlericalismo arcaico.
Le Camere tornarono a riunirsi nei palazzi antichi, anziché voltare pagine utilizzando, per esempio, quelli edificati nel quartiere dell'Eur. Le divisioni rimasero e durarono persino oltre il crollo dell'Urss.
Ma in tempo di emergenze il problema è solo la vetustà degli edifici? L'orizzonte non è affatto sereno. Non solo per le vittime quotidiane del “virus” ma per le ripercussioni che questo avrà sul futuro di un Paese fragile, da tempo allo stremo delle risorse, costretto a potare gli investimenti e ora disorientato da altalenanti bollettini quotidiani sull'andamento del “contagio”, dal cumulo di decreti e ordinanze “a singhiozzo”, sempre meno sopportabili. Chi ha la responsabilità del governo non può pretendere fiducia “in bianco” a tempo indeterminato senza indicare ai cittadini prospettive chiare, tanto più a Camere socchiuse.
Aldo A. MOLA